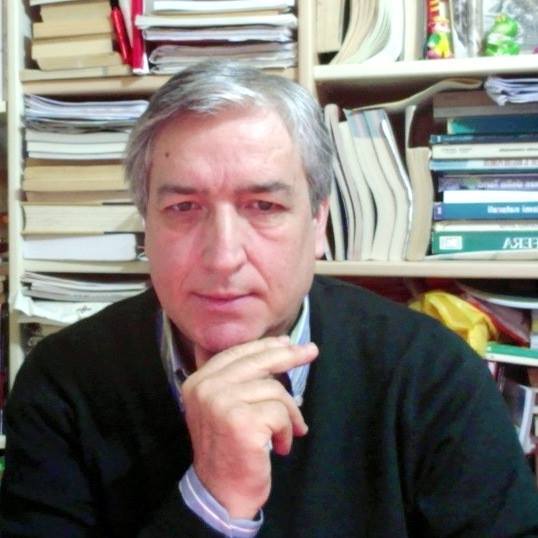
Trebisacce-27/02/2025: Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie Qualche riflessione sulla Rivoluzione Industriale, ieri e oggi di Salvatore La Moglie

Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Qualche riflessione sulla Rivoluzione Industriale, ieri e oggi
di Salvatore La Moglie
Ha scritto il grande storico Eric Hobsbawm che la Rivoluzione industriale inglese è stata la più grande rivoluzione economica e sociale dopo quella del Neolitico, cioè dopo l’età della pietra nuova, quando, circa diecimila anni fa, l’uomo imparò a coltivare la terra e a addomesticare gli animali dando vita a quella Rivoluzione agricola che avrebbe cambiato la vita degli uomini che, da nomadi, diventarono stanziali e incominciarono a costruire le prime società e le prime civiltà, quelle fluviali o idrauliche che sono state la culla della civiltà nell’accezione più ampia di questa espressione. Secondo l’autore del fortunato Secolo breve gli uomini, per parecchi millenni, sarebbero stati sostanzialmente fermi fino a quando non avvenne l’altra rivoluzionaria svolta storica segnata, appunto, dalla nascita delle fabbriche e delle industrie prima in Inghilterra e poi, man mano, nell’intero mondo. Con la Rivoluzione Industriale la Modernità deflagra, esplode in tutto il suo vitalismo: le trasformazioni sociali, economiche, culturali e mentali saranno enormi e aldilà di ogni previsione e immaginazione ma, prima di fare qualche riflessione su di essa, ci sembra opportuno fornire almeno un quadro schematico di quello che avvenne di importante nel 1600, che è, poi, il secolo che la prepara.
L’economia-mondo europea tra Antico Regime e Mondo Moderno
Nel 1600 si ebbe un notevole incremento demografico, tanto che nel 1700 la popolazione dell’Europa raggiungerà i 118.000.000 di abitanti. In Inghilterra, diversamente dagli altri paesi europei un po’ più arretrati, si ebbe una rivoluzione agricola. Cessò il fenomeno dei campi aperti che vennero recintati dai proprietari e sfruttati in senso capitalistico, ponendo così fine ad un certo retaggio medievale e feudale. Quindi prevalse il sistema delle enclosures (cioè, dei campi chiusi). Il metodo di coltivazione era quello della rotazione triennale a maggese. Una situazione, per l’agricoltura, simile a quella dell’Inghilterra, c’era soltanto nella Germania Settentrionale, nei Paesi Bassi, in Danimarca e, in Italia, nella Pianura Padana. In Inghilterra i terreni saranno sfruttati in senso capitalistico e questo condurrà a quello che gli economisti chiamano accumulazione primitiva: accumulazione, cioè, di capitali e di ricchezza monetaria che, poi, sarà in parte destinata al processo di industrializzazione del paese. Nel ‘600 si diffusero molte colture come il mais o granoturco e la patata dell’America Meridionale e prodotti come lo zucchero, il thè, il cacao e il caffè importati dal Nuovo Mondo in seguito alle scoperte geografiche.
Tra il ‘600 e il ‘700 si era nella fase che gli storici chiamano protoindustriale: si era diffuso il sistema del lavoro a domicilio, detto anche manifattura dispersa. Questo sistema era incentrato sulla figura del mercante-imprenditore che acquistava le materie prime e le affidava alla famiglia contadina. Per quanto riguarda i traffici commerciali, gli storici parlano di commercio triangolare tra Europa, Africa e America, per cui nel ‘600 si affermò la cosiddetta economia-mondo europea, cioè una prima forma di mondializzazione, di globalizzazione, cioè di integrazione delle economie. Da questo momento l’Europa occidentale è al centro della storia, è il motore stesso della storia del mondo, per cui si parla di eurocentrismo, concetto e realtà che entreranno in crisi con la Prima Guerra Mondiale e cesseranno del tutto con la Seconda.
I dominatori dell’economia-mondo erano la Francia e l’Inghilterra che avrebbero agito sempre più a danno della Spagna, del Portogallo e dell’Olanda destinati a un lento ma irreversibile declino. In questa gara colonialista la Gran Bretagna, all’inizio del ‘700, avrebbe ottenuto l’asiento, cioè il monopolio del commercio di esseri umani, rinvigorendo la famigerata tratta degli schiavi. La competizione e il contrasto anglo-francese nelle Americhe sarebbe sfociata nella prevalenza dell’Inghilterra che, in varie fasi e anche con delle guerre, riuscirà a sottrarre alla Francia vasti territori. Nel ‘600 sarebbe iniziata anche la colonizzazione dell’Asia. In seguito, in pieno ‘800, il colonialismo si sarebbe trasformato in imperialismo (che rappresenta la fase estrema del capitalismo), per cui sarebbero sorti dei veri e propri imperi politici, militari, economici e commerciali. A livello economico si affermò la teoria del mercantilismo, che era incentrata sull’intervento dello Stato. Essa faceva consistere la ricchezza di un paese nel commercio di oro e argento e teorizzava il protezionismo, cioè l’imposizione di tasse doganali agli altri Stati per la protezione, appunto, dei prodotti nazionali. Poi, dal ‘700 in poi, prevarrà il liberismo con, a fasi alterne, il protezionismo, fino ad arrivare all’attuale imperante neoliberismo.
Le ragioni del primato inglese, ovvero: perché la Rivoluzione Industriale è scoppiata in Inghilterra
Naturalmente, la Rivoluzione Industriale non venne dal nulla e fu determinata da un insieme di fattori. Vediamoli.
Aver (l’Inghilterra) buttato per prima nella spazzatura della Storia (come direbbe Trotsky) le scorie (direbbe a sua volta Croce) del passato, cioè i legami e i residui del feudalesimo; la presenza di un ampio mercato interno alimentato dall’aumento demografico; dalla trasformazione qualitativa dei metodi di coltivazione della terra (Rivoluzione Agricola) e dall’espansione dei commerci e delle manifatture; la supremazia nei commerci internazionali, grazie ai possedimenti coloniali e all’imponente flotta commerciale, costituivano un grande stimolo per la vita economica del paese, poiché da un lato consentivano l’approvvigionamento di materie prime (come il cotone) a basso costo, dall’altro garantivano vasti mercati di sbocco per la vendita dei prodotti nazionali; la diffusa presenza di una mentalità imprenditoriale nell’alta borghesia (proprietari terrieri, mercanti-imprenditori) e nel ceto medio (bottegai, artigiani), per cui si era disposti a rischiare i propri capitali pur di fare profitti; c’era poi la gentry, che era la piccola nobiltà di campagna, molto intraprendente, che non si vergognava (come quelli della nobiltà europea) di dirigere le proprie aziende agricole; la grande disponibilità di mano d’opera che accettava di lavorare anche per salari molto bassi, in conseguenza della crescita della popolazione sia dell’espulsione di molti contadini dalle campagne, a causa della recinzione e della privatizzazione delle terre comuni; la consolidata esperienza nel campo della manifattura tessile che, nel settore laniero, primeggiava da tempo in Europa; l’abbondante disponibilità di ferro e carbone, materie prime che si rivelarono di vitale importanza per lo sviluppo industriale; la presenza di un efficiente sistema di vie di comunicazione essenziale per la circolazione di uomini e merci.
A queste condizioni di carattere socio-economico si aggiunsero, poi, importanti fattori di carattere culturale e di mentalità. Fin dal basso medioevo l’Inghilterra poteva vantare di essere un paese con una certa filosofia e con certo un modo di pensare, soprattutto in merito all’osservazione diretta dei fenomeni naturali e all’innovazione tecnologica finalizzata alla soluzione dei problemi pratici. Intellettuali come Francesco Bacone, John Locke, Isacco Newton, David Hume ecc. avevano contribuito in modo decisivo a orientare la cultura inglese in senso empiristico, considerando l’esperienza diretta come sola e vera fonte di conoscenza. Un tale clima culturale non poteva non contribuito a diffondere presso tutti gli strati sociali una mentalità pratica, pragmatica, empirica, attenta a proporre soluzioni concrete ai problemi economici e sociali.
Rivoluzione industriale: effetti e conseguenze
La Rivoluzione Industriale, che dall’Inghilterra si sarebbe poi, nell’800, estesa all’intera Europa, ebbe più di un effetto e più di una conseguenza, e questo nel breve come nel medio e lungo periodo, cioè fino ai nostri giorni, e nel bene e nel male. Abbiamo cercato di stilare un elenco ragionato in più punti (che potrebbero essere anche molti di più). Vediamo.
Nasce un nuovo luogo di lavoro, la fabbrica, e nasce una nuova classe sociale, il proletariato. Si affermano le macchine e con esse il macchinismo e la meccanizzazione. Con il macchinismo, la meccanizzazione e poi l’automazione (soprattutto nel ‘900) si ha il fenomeno della disoccupazione di massa; già agli inizi sorse il fenomeno del luddismo (da John Ludd), cioè dell’avversione per le macchine, tanto da distruggerle. Sorgono e si sviluppano Il movimento operaio si organizza e trova i propri supporti nell’ideologia del Socialismo, nei primi partiti socialisti e nei sindacati; dopo il 1848, con la pubblicazione de Il manifesto del partito comunista di Marx ed Engels, si afferma la concezione comunista della rivoluzione proletaria, che sarà per decenni lo spettro che si aggira per l’Europa. Intanto, cresce e si impone sempre di più il dominio della classe borghese, del capitalismo e dell’economia di mercato, con al centro la proprietà privata; nascono le borse e si sviluppa il sistema bancario e finanziario. Il corrispettivo del liberalismo in economia è il liberismo, che esalta la libera circolazione delle merci, il mercato e la non ingerenza dello Stato nella vita economica di un paese. Avviene lo spostamento in massa dalle campagne alle città. Si tratta del fenomeno dell’urbanesimo o urbanizzazione. Non sempre, però, andando in città e nelle fabbriche, si migliorava il proprio destino, anzi, spesso si ingrossavano le file dei mendicanti, dei disperati e degli emarginati sociali in genere (si pensi alla prostituzione, all’accattonaggio e alla criminalità). Incomincia a presentarsi e a diffondersi il fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Le società dei paesi europei, con lo sviluppo della Rivoluzione Industriale in ogni settore e in ogni campo della vita economica e sociale, cominciano a diventare società complesse e di massa. Si sviluppano i mezzi di comunicazione di massa e il giornalismo; ci si avvia verso una civiltà consumistica e sempre più basata sull’immagine (si pensi al cinematografo e alla televisione). Già verso la fine dell’Ottocento sorge e si sviluppa il movimento di emancipazione della donna. Intanto, grandi progressi si hanno nell’igiene, nell’alimentazione, nel campo della medicina e della biologia; vengono scoperti, man mano, vaccini, nuove medicine ecc. che hanno salvato milioni di vite umane; grande sviluppo si ha anche nel campo della fisica (si pensi per esempio a Einstein, Enrico Fermi, Oppenheimer, ecc.), sviluppo che avrebbe portato alla costruzione della bomba atomica, con lo spettro della catastrofe nucleare e dell’autodistruzione dell’uomo. Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, dopo la prevalenza della catena di montaggio e delle teorie di Taylor (taylorismo), le modalità di lavoro nelle industrie e nelle fabbriche sono cambiate e grande sviluppato ha avuto il settore terziario, cioè dei servizi, tanto che si parla di società post-moderna o post- industriale o post-capitalistica. Lo sviluppo scientifico e tecnologico è stato tale da consentire all’uomo di esplorare lo spazio e andare sulla luna, di costruire i più sofisticati satelliti e anche le armi più sofisticatamente e più intelligentemente micidiali; negli ultimi decenni, tra XX e XXI secolo, la tecnologia si è sviluppata fino alle attuali nanotecnologie, bio-tecnologie, micro-elettronica; ingegneria e manipolazione genetica, fino a creare l’uomo in vitro e sperimentare la clonazione. Attualmente la nostra era della globalizzazione neoliberista è dominata dalla televisione, dai computer, da internet e dai cellulari a tecnologia più avanzata che, secondo la fortunata espressione coniata da Marshall Mc Luhan per il fenomeno della televisione, hanno davvero reso il mondo un villaggio globale anche se, forse, stanno rendendo l’uomo più solo, nonostante l’apparente socializzazione attraverso i social network, facebook primo fra tutti.
Come si può vedere, non mancano i lati positivi e quelli negativi della Rivoluzione Industriale nella sua lunga marcia dalla metà del Settecento ad oggi e, forse, la conclusione è che i secondi superano i primi come, del resto, aveva già mostrato efficacemente Charles Dickens nei suoi romanzi. Da quando i capitani coraggiosi dell’Inghilterra iniziarono questa Rivoluzione, armati si idee e soprattutto di hybris, cioè di senso della sfida, alla stessa natura e forse anche a Dio, come ben ha spiegato lo storico David Landes nel suo stupendo libro Il Prometeo liberato, ebbene, da allora, il mondo ha voltato pagina e ha cambiato volto: da un mondo e da una società tradizionali, semplici si è passati a un mondo e a una società complessi (la complessità) nei quali è risultato sempre più difficile e problematico vivere e abitare. Di questi chapliniani Tempi moderni, di questo mondo nuovo con le sue storture, le sue incongruenze, i suoi falsi valori, i suoi pseudo-ideali, le sue ingiustizie e le sue violenze contro l’uomo e la stessa natura si accorsero subito intellettuali illuminati come Rousseau e poi quelli romantici come il nostro Leopardi e, più in là, tra ‘800 e ‘900, grandi realisti come Zola e Verga e gli scrittori e i poeti del Decadentismo europeo che faranno un’analisi spietata e corrosiva della civiltà industriale borghese e della modernità che da essa era scaturita. Kafka, Musil, Proust, Mann, Pirandello e Svevo, per es., ritenevano la modernità borghese una trappola mortale e la società allora messa in piedi come ammalante, alienante, da nevrosi, inquinata alle radici (Svevo) e, quindi, impossibile da salvare se non forse attraverso un’enorme, inedita deflagrazione che avrebbe fatto ritornare il mondo alle origini per poi ricominciare di nuovo, con la speranza-utopia di una terra più sana e meno malata e di un mondo meno alla rovescia. Svevo, con la sua Coscienza di Zeno, rappresenta probabilmente il culmine della critica alla modernità e alla società borghese industriale che non può che essere alienante e da malattia psichica e, soprattutto, portatrice di morte e di apocalisse. E, infatti, mentre Svevo scriveva, sui campi di battaglia di mezza Europa si combatteva la prima guerra di livello mondiale, con tutte le conseguenze che si conoscono, tra le quali vi furono la Rivoluzione Sovietica e quindi l’affermarsi dello Stalinismo e l’avvento, in Italia, del Fascismo e poi del Nazismo in Germania, favorito anche dalla seconda grande crisi del capitalismo mondiale dopo quella del 1873-96: la crisi del 1929 con il crollo della borsa di Wall Street. Quindi, tra totalitarismi, Seconda Guerra Mondiale, Guerra Fredda e crollo del Muro di Berlino e dell’Impero Sovietico, il mondo capitalistico ha continuato a vivere e la Rivoluzione Industriale globalizzata ha proseguito imperterrita il suo cammino, la sua lunga marcia, ancora con aspetti positivi e negativi, certamente più negativi che positivi, come negli anni Sessanta e Settanta del Novecento faceva già notare, in disperata solitudine, il mai tanto rimpianto Pier Paolo Pasolini, il quale poneva l’accento non sul progresso ma teneva a sottolineare come ciò che più che lo preoccupava era il tipo di sviluppo che la civiltà capitalistica e il processo industriale avevano intrapreso. Di qui la sua analisi corrosiva, la sua durissima contestazione e la continua polemica contro una civiltà consumistica che aveva provocato una vera e propria mutazione antropologica degli italiani, riducendoli ad un conformismo e ad un appiattimento che neppure il fascismo era stato capace di realizzare. Era stato profetico Pasolini, aveva previsto, con le sole armi della poesia, lo scenario di un mondo terribile, crudele, alienante, conformizzante, da pensiero unico e da uomo a una dimensione (Marcuse) che si voleva imporre (e si è ormai imposto…) agli uomini, con il fine certamente non molto nobile di renderli fintamente più liberi ma, nella sostanza, più sudditi e più servi, più disperati, più passivizzati e anestetizzati, più precarizzati e con meno diritti, possibilmente senza più alcuna vera presa di coscienza sulla realtà.
