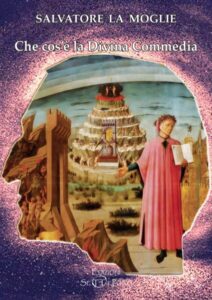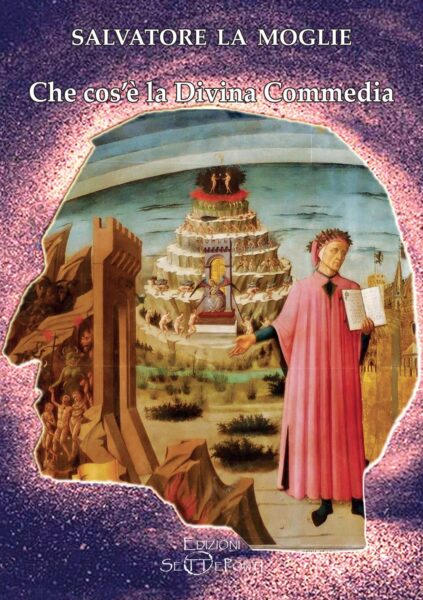
Trebisacce-21/04/2025: Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie Qui di seguito viene pubblicata il “secondo capitolo” del saggio di Salvatore La Moglie “Che cos’è la Divina Commedia” edito dalla casa editrice Setteponti di Arezzo nel 2022.

Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Qui di seguito viene pubblicata il “secondo capitolo” del saggio di Salvatore La Moglie “Che cos’è la Divina Commedia” edito dalla casa editrice Setteponti di Arezzo nel 2022.
Il Divino Poeta era profondamente convinto (per sintesi di ragionamento filosofico e teologico insieme, che gli proveniva dalla Scolastica ma anche da tante altre letture, da altre fonti e autorità culturali) che sia nella vita individuale che in quella politica occorresse la perfetta sintonia di Fede e Ragione e, quindi, dei due Soli, cioè di Papato e Impero, del Potere politico imperiale (di stampo Romano) e del Potere spirituale esercitato dalla Chiesa, la quale deve rinunciare al potere temporale, cioè politico, e operare soltanto in senso religioso e spirituale. I due massimi sistemi, i due massimi Poteri universali non devono combattersi l’un l’altro (come era accaduto durante il Medioevo) ma devono collaborare, ciascuno autonomo nella propria sfera, per il bene dell’umanità, sia per quanto concerne il benessere, la felicità terrena che per quanto concerne il benessere, la felicità spirituale, ultraterrena. Perché se è vero, come si credeva nel Medioevo, che il mondo terreno è una valle di lacrime e la vera realtà è quella ultraterrena, quella dell’aldilà dove troveremo la felicità eterna, è anche vero – per Dante – che la felicità e il benessere terreno e ultramondano possono essere favoriti dal giusto procedere di conserva delle due alte guide, l’Imperatore e il Papa, il pastor della chiesa. Ora, ai tempi di Dante, questa visione appariva come una vera e propria utopia. Perché? Perché sia l’Impero che il Papato erano due autorità, due istituzioni in profonda crisi e in declino e l’avvento di Arrigo (Enrico) VII di Lussemburgo, apparso come una meteora, non fu che una pia illusione, un sogno impossibile che non si sarebbe mai potuto realizzare. Ormai da lungo tempo la Storia stava imponendo sulla scena le grandi Monarchie (o Stati) nazionali e altre entità minori come i Comuni e poi i Principati, le Signorie, gli Stati regionali in lotta proprio contro le due grandi istituzioni medievali e anche tra di loro per la propria affermazione e/o per la propria espansione a danno degli altri. Eppure per il passatista, l’antistoricista e antimoderno Dante, per il Dante che appare spesso come un retrogrado, un conservatore, un laudator temporis acti, l’unica salvezza di fronte a tanta orribile corruzione e perdizione dell’umanità poteva essere soltanto la collaborazione perfetta tra Impero e Papato, ovvero tra due Poteri, due entità sovranazionali (del resto, da anni ormai, le nazioni europee non hanno pensato che il bene può venire soltanto da un’Europa unita e, quindi, da un’entità sovranazionale che è stata chiamata UE, Unione Europea e, prima ancora, non si è pensato a una Società delle Nazioni e poi all’ONU, cioè ad un’organismo sovranazionale di Nazioni Unite al fine di impedire le guerre e cercare di mantenere la pace, frenando gli egoismi, le prepotenze e la volontà di sopraffazione dei singoli Stati?). Insomma, nel proporre la collaborazione tra Impero e Papato per la felicità dei popoli, sia terrena che spirituale, Dante (con mentalità moderna e lungimirante) non negava il diritto all’esistenza, cioè riconosceva le nuove realtà collettive come Comuni, Città-Stato e Nazioni (che difendevano la propria autonomia) ma egli era convinto che per avere una pace e una giustizia durature, perpetue tra i popoli e tra le società occorresse la presenza di un potere sopra le parti (quello, appunto, della Monarchia Universale di stampo Romano) che facesse da garante, da freno e da censura nei confronti delle pretese e degli egoismi particolari, una sorta di Super-Io sovranazionale (direbbe Freud) di fronte al quale sarebbe dovuta scattare subito l’autocensura, già a livello di inconscio.
Per Dante (che, in merito al rapporto Stato-Chiesa, Politica e Religione, con spirito moderno, anticipa di cinque secoli il libera Chiesa in libero Stato di Cavour), il mondo nuovo, il Nuovo Ordine Mondiale che si stava prepotentemente affermando conduceva alla lacerazione, alla divisione anziché alla coesione, alla deriva totale fino alla catastrofe e alla fine del mondo; un mondo ormai imbarbarito e, certo, avrebbe condiviso le parole di Johann Gottfried Herder: Noi ci troviamo all’orlo dell’abisso della barbarie. Era (come quello di oggi…) un mondo alla rovescia, generatore di disordine, di caos e di violenza, senza Dio e senza Cristo, orribilmente materialista e prosaico, orribilmente sporco e ignorante (direbbe Pasolini) che lui avrebbe voluto salvare, rifare, rifondare, rimettere in ordine, raddrizzare. La classe borghese e mercantile che si sta imponendo un po’ ovunque facendo prevalere il suo economicismo ovvero i valori e gli ideali della roba (dirà, secoli dopo, Verga), del profitto, del successo, della scalata sociale, del denaro e del guadagno facili che generano invidia, odio, tracotanza, prepotenza, arroganza e violenza (la gente nova e i sùbiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata, scrive con forte disappunto nel XVI dell’Inferno), questa nuova inedita classe sociale, destinata a imporsi sulla scena del mondo definitivamente nel 1800, non piace al Sommo Poeta (pasoliniano ante litteram) che finisce per passare come antistorico, antimoderno e addirittura reazionario e conservatore, proprio come è successo a Pier Paolo Pasolini che (provocatoriamente) in una poesia si autodefinisce una forza del Passato e che non amava la civiltà del consumismo che omologa e conformizza più del fascismo, generando una orribile mutazione antropologica. Come Pasolini, il Sommo non era contro il progresso ma contro un certo tipo di sviluppo, contro una certa direzione verso cui una società, un paese o anche il mondo stesso sono indirizzati dai ceti dominanti che hanno nelle mani le leve del Potere. Dante aveva compreso con chiarezza che ormai si era di fronte ad un cambiamento epocale, ad un vero e proprio spartiacque per cui c’era un prima e un dopo e che nulla sarebbe più stato come prima e che, adesso, i tempi passati, il come eravamo si potevano solo rimpiangere e averne una struggente nostalgia. Insomma, anche il pasoliniano Dante si avvedeva, con orrore, che la civiltà, il mondo scristianizzato e laicizzato del suo tempo (che i posteri, dice nel canto XVII del Paradiso, chiameranno antico) precipitava verso un orribile baratro morale, spirituale, culturale e, soprattutto, verso un’orribile mutazione antropologica che distrugge irrimediabilmente i veri valori e ideali in cui l’uomo deve credere e dai quali deve farsi guidare durante la propria esistenza. E quali sono per Dante questi valori e ideali? Sono certamente l’Amore, il Bene, la Verità, la Giustizia, la Virtù, la Bellezza, l’Etica, la Rettitudine, la Fratellanza, la Solidarietà, la Pace e insomma tutti quei valori che sono il contrario di quella cosa terribile e orribile che il Divino Poeta chiama Malizia, parola che racchiude tutte le altre negative di cui l’uomo, purtroppo, è intriso e di cui è capace, fino a provocare delitti o guerre e cioè: il Male, la Cattiveria, la Prepotenza, l’Invidia, la Gelosia, la Lussuria, l’Intolleranza, l’Orgoglio, l’Arroganza, la Cupidigia, la Forza, l’Inganno, la Fraudolenza, il Tradimento, la Calunnia, il Malaffare, l’Immoralità, la Violenza in ogni sua espressione (anche quella della Storia sugli uomini) e via discorrendo.
Nella Divina Commedia c’è tutto questo, cioè tutto l’orrore di cui l’uomo è capace su quello che Antonio Gramsci chiamava il mondo grande e terribile, un orrore per cui la Terra su cui viviamo finisce per divenire l’aiuola che ci fa tanto feroci (Paradiso, XXII). Nel gran mar dell’essere (Paradiso, I) c’è tutta l’umanità nelle sue varie espressioni e sfaccettature, quella che compie imperterrita il Male e che sarà punita, per l’eternità, nell’Inferno e quella che lo subisce e che può solo aspirare a una giustizia divina e alla beatitudine eterna del Paradiso, dove a regnare è il perfetto e armonico ordine divino, tutt’altra cosa rispetto all’inferno costruito dall’uomo sulla Terra. Mai, come nel caso di Dante, la frase di Jean-Paul Sartre, l’inferno sono gli altri, risulta estremamente calzante: il problema sono sempre gli altri e il bene o il male che sono capaci di fare al prossimo e alla società in cui vivono e operano. Per Dante erano stati gli altri a creargli l’inferno sulla terra, erano stati i legni storti, erano stati dei malnati, dei corrotti e degenerati uomini-feccia, di basso livello morale, culturale e politico che agivano per il proprio particulare (come diceva Francesco Guicciardini) e non per il bene della comunità. Ed è contro questo tipo di uomo e contro questa umanità che Dante lancia il suo urlo e scrive la Commedia, sognando che un giorno possa esserci un nuovo uomo e una nuova umanità. Insomma, la “vendetta”, la risposta e la resistenza di Dante (senza colpo ferire!) a tanto male che gli uomini fanno sulla Terra e che a lui hanno fatto, è l’arma della Poesia (direbbe Pasolini), l’arma della Cultura che, solo apparentemente, è un’arma innocua, un’arma da niente ma, in verità, sia nel breve che nel medio e anche nel lungo periodo, anche nella distanza fatta di secoli, si rivela un’arma potentissima, capace di rendere Giustizia e di vendicarsi contro le offese del mondo e di uomini…a mal più ch’a bene usi (Paradiso, III). Le sole armi della parola scritta, della Poesia e della Cultura contro la prosaicità e l’impoeticità del mondo, e Dante era fortemente convinto e consapevole che la sua Commedia gli avrebbe reso Giustizia oltre che la fama e la gloria eterne, mentre gli uomini-feccia, i malnati e tutti i piccoli uomini politici del suo tempo narrati nel suo romanzo sarebbero stati immortalati nella loro malvagità, nella loro pochezza, nella loro miseria morale, spirituale e culturale. Sono loro che nel VI del Purgatorio gli fanno uscire dal più profondo dell’animo il disperato e durissimo urlo-j’accuse (forse il più potente ed emblematico di tutta la Commedia) sulla serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province ma bordello.
Dante getta uno sguardo lucido e impietoso sugli inganni e gli abusi che reggono la vita civile; egli rifiuta con ostinazione le ambiguità, i compromessi, le mistificazioni presenti nelle ideologie che cominciano a svilupparsi nel secolo XIV. Nel suo percorso verso una verità che sia eterna e indubitabile, nel suo tentativo di uscire dalla frammentarietà, dall’insufficienza, in una parola dalla finitudine dell’esistenza umana, il poeta denuncia non solo il male che si annida in situazioni storiche contingenti, ma anche i limiti di ogni sviluppo storico. La scrittura è così contraddizione continua, che crea tensioni e opposizioni, come a rendere manifesti i segni di un conflitto, a tenere i lettori sempre all’erta. Nella rete infinita di significati polivalenti, di rimandi alla letteratura e alla realtà storica, di registri e di toni, nella Commedia d’altra parte sempre in primo piano è la figura umana e intellettuale dell’autore, con la sua ricerca solitaria di verità e di giustizia: così sottolinea opportunamente Giulio Ferroni nella sua Storia della letteratura italiana (Einaudi, 1991).
Da notare e da sottolineare, da parte nostra, è il fatto che nella Commedia in generale e nell’Inferno in particolare, gli emblematici, paradigmatici peccatori passati in rassegna non sono quelli della strada, la gente comune ma quelli del sistema, delle élites, dell’establishment, dei ceti medio-alti, quelli delle classi dirigenti, i potenti della politica, dell’economia e del mondo religioso, cioè gli uomini di chiesa, i papi e gli alti prelati presentati come dei veri e propri criminali che, in nome del proprio particulare, dei propri egoistici e meschini interessi personali o di parte, si sono macchiati di delitti, peccati, colpe orribili, imperdonabili contro il prossimo e contro la collettività e che appartengono sia al passato più remoto (anche mitologico) che ai tempi di Dante o giù di lì. E il Sommo li condanna per l’eternità, per l’oggi e per il domani, appunto come eterno monito in quanto vuol dimostrare che loro che erano al Potere, nei posti di comando e di rilievo nella società, avrebbero dovuto essere di esempio, da modello per tutti gli altri e condurre la loro vita con onore, onestà e, insomma, con moralità irreprensibile e, invece, hanno fatto tutto il contrario: hanno vissuto e operato con basso livello etico e non sono stati un paradigma, un modello, un esempio per gli altri ceti, per tutti gli altri cittadini e, anzi, hanno reso di massa comportamenti illeciti, disonesti e illegali fatti passare come normali. E quando il pesce puzza dalla testa, quando cioè le classi dirigenti non costituiscono un esempio per tutta la collettività, è allora che la corruzione e i comportamenti illegali si diffondono e una società diventa marcia fino alle radici e, pertanto, tutto appare putrefazione e degenerazione e ogni speranza di salvezza e di rifondazione e recupero dei veri valori appare impossibile. Insomma, per Dante (e soprattutto nell’Inferno appare come un chiodo fisso, una vera ossessione), i più grandi colpevoli e responsabili della crisi dei valori morali, spirituali e delle degenerazioni in una società come nel mondo intero, sono le classi dirigenti, gli uomini che, a vario livello, hanno le leve del potere e del comando politico ed economico e che avrebbero dovuto essere un paradigma, un modello etico per tutti gli altri cittadini, esempi da imitare e non lo sono stati e, inoltre, le loro scelte e decisioni politiche hanno avuto effetti e conseguenze spesso devastanti sui singoli come sulle comunità. E il microcosmo Firenze, ai suoi occhi, era diventato emblematico, praticamente una metafora di tutti i mali che avvolgevano il macrocosmo, cioè il mondo intero. Nella Commedia è come se lui dicesse a tutti i legni storti e a tutti gli uomini-feccia dell’Inferno ma anche agli espianti del Purgatorio: Voi avreste dovuto essere d’esempio per tutti gli altri e, invece, vi siete comportati come i peggiori, con effetti deleteri sui governati, ed è per questo che ora siete qui così adeguatamente puniti. Purtroppo, nulla è cambiato dai tempi di Dante ed è anche per questo che sia lui che la sua opera sono sempre di scottante attualità, sono un immortale classico che regge bene alla sfida del Tempo. Dante ci parla ancora e continuerà a parlare a coloro che verranno, vorrebbe che lo ascoltassimo e che lo seguissimo nel suo straordinario percorso e che il suo folle viaggio fosse il nostro, anche soltanto con la mente e il cuore in sintonia con lui. È come se lui ci dicesse: Se mi seguite, un altro mondo può essere possibile: basta farsi guidare dai Lumi della Ragione e della Fede. Il viaggio lo fa lui ma quel lui, quel soggetto, quell’individuo, quell’io vuole essere un io collettivo, è come se fosse un noi universale sia perché Dante simboleggia l’umanità peccatrice alla ricerca della sua vera, originaria umanità e della sua vera, autentica anima, sia perché Dante è per l’universale noi e non per l’egoistico e distruttivo io, quell’io (il detestabile io, direbbe Pascal) che pensa soltanto a come arricchirsi (spesso anche a danno degli altri), che crea solo odio, invidia, superbia, arroganza e porta alle peggiori nefandezze, al delitto, alla corruzione, alle degenerazioni, alle lacerazioni più profonde nel tessuto sociale e alle guerre, che sono il culmine della bestialità e degli orrori umani. (2-Continua)