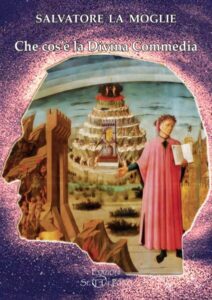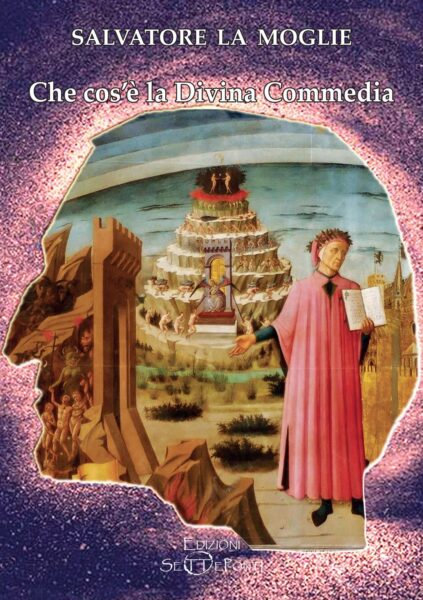
Trebisacce-24/05/2025: Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie

Rubrica storico-letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Qui di seguito viene pubblicato il “terzo capitolo” del saggio di Salvatore La Moglie “Che cos’è la Divina Commedia” edito dalla casa editrice Setteponti di Arezzo nel 2022.
In Dante c’è tutto o quasi. Dante non è solo il padre della lingua italiana ma anche il padre della letteratura italiana e, infatti, in Dante e nella Commedia – che rappresenta il momento più alto del suo sperimentalismo linguistico e letterario – sono, racchiusi, lo ripetiamo, un po’ tutti i generi: la poesia, il poema, il trattato, il saggio, il dramma, la tragedia, il romanzo, il racconto, la fiaba, il mito, il teatro, la tecnica impressionistica nel raccontare come nel descrivere una scena, la tecnica cinematografica, il film a puntate, a episodi e, insomma, il cosiddetto romanzo sceneggiato. Non solo, ma Dante anticipa l’Umanesimo e anzi è il primo degli umanisti sia per quanto riguarda il suo amore per i classici greci e latini (il cui studio serve per elevare moralmente e spiritualmente), che per la sua visione della letteratura e della cultura come le uniche che possano elevare l’uomo fino alle vette più alte e al sublime e, ben collegato a questo, per il fatto di mettere al centro della sua Weltanschauung, della visione globale e del discorso letterario, l’uomo con la sua intelligenza, i suoi veri valori e ideali, l’uomo creato da Dio, posto come signore sulla Terra ma anche responsabile delle proprie azioni, del suo libero arbitrio e che, quindi, può essere costruttore, artefice del proprio destino e della propria fortuna. L’uomo che è un microcosmo che deve riflettere il macrocosmo ovvero il mondo, l’universo ordinato e armonioso creato dalla Potenza Divina. E Dante, nella Commedia, ci appare, lui stesso, proprio come un microcosmo, un microcosmo che sa tutto e, quindi, ha ragione Novalis a scrivere che il vero poeta è onnisciente: è realmente un microcosmo. Un emblematico e allegorico microcosmo e, infatti, nella Commedia in modo particolare e, un po’ anche in tutte le sue opere, sembra riecheggiare e dominare il motto umanistico di Terenzio che pone l’uomo, l’amore per l’uomo e tra gli uomini al centro del proprio interesse: Sono un uomo: niente di ciò che è umano mi è estraneo (Homo sum, humani nihil a me alienum puto). Del resto, a un genio come Dante non interessava parlare meramente di se stesso, far spiccare il suo caso personale e, magari, atteggiarsi a povera vittima; no, a lui interessava fare della sua vicenda personale qualcosa di universale, che fosse esemplare, emblematica, memorabile e che, appunto, riuscisse a rappresentare il macrocosmo. Nel lontano 1952, durante una conferenza a Parigi, colse bene Vitaliano Brancati quando, per spiegare l’individuale-universale dolore di Leopardi, disse che l’Universale…sceglie sempre, per venire alla luce, la via più stretta, quella del particolare. Ma è un particolare che riesce ad assurgere a metafora dell’universale per l’oggi e per il domani. E si potrebbe citare anche quello che un giorno del 1784 Goethe scrisse a Johann K. Lavater: Ti ho già scritto la parola individuum est ineffabile da cui deduco un mondo? Ecco: dall’individuo Dante noi possiamo e dobbiamo dedurre tutto un mondo. Ed era questo che lui voleva dai suoi contemporanei e soprattutto dai posteri.
Un’altra cosa importante da rilevare è che Dante, suo malgrado, è l’iniziatore di quel filone letterario dell’intellettuale cortigiano (proprio della civilità umanistico-rinascimentale) che vivendo, appunto, presso la corte di un Principe o di un Signore e, cioè, all’ombra del Potere, non può permettersi il lusso di sputare nel piatto in cui mangia e, anzi, deve adularlo e dedicare i libri che scrive ora a questo Signore e poi a quest’altro. Questo tipo di intellettuale che vive a corte, che è ben pagato per la sua attività culturale lo continuerà (non suo malgrado…) Francesco Petrarca, al quale denaro, onori e gloria non facevano certo ribrezzo. Poi diventerà un fenomeno stabile, normale durante tutta la civiltà umanistico-rinascimentale fino a diventare (nel tempo) una caratteristica di un po’ tutti gli intellettuali che, fino ai nostri giorni, preferiscono – diciamo così – vivere all’ombra del Potere, avere un buon rapporto con il Potere e il Potente di turno anziché contestarli e combatterli, tanto da diventare organici, funzionali e, insomma, sovrastruttura indispensabile di ogni establishment e loro stessi establishment. Dicevo che Dante è stato l’iniziatore ma (va sottolineato) solo suo malgrado di questo tipo di intellettuale, suo malgrado perché la tragedia dell’esilio lo costrinse a salire e scendere per l’altrui scale e a provare come sa di sale lo pane altrui (Paradiso, XVII). Non solo, ma l’esilio, la condizione di ghibellin fuggiasco (Ugo Foscolo), di bandito, di fuorilegge l’aveva reso un fuoriuscito, un déraciné, uno sradicato, una sorta di apolide, un senzapatria, un cosmopolita (anche questa volta suo malgrado), tanto che nel De vulgari eloquentia scrive che: ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare. Ma l’esilio è la condizione naturale del poeta, ha scritto metaforicamente il Premio Nobel russo Josif Brodskij e questo pensiero sarebbe certamente piaciuto al Sommo. Sulla sua condizione di esiliato, così, Dante, scriverà nel Convivio: “Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno (…) per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contro mia voglia la piaga de la fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade ; e sono apparito a li occhi a molti che forseché per alcuna fama in altra forma m’aveano imaginato, nel conspetto de’ quali non solamente la mia persona invilìo, ma di minor pregio si fece ogni opera sì già fatta, come quella che fosse a fare.
Comunque, di una situazione di debolezza, di fragilità Dante sarà capace di farne un punto di forza, se ne farà una corazza e, insomma, da una situazione di crisi in cui venne a trovarsi, lui non ne uscirà distrutto, non ne uscirà sconfitto ma vittorioso: l’esilio lo farà diventare Sommo ed eterno: Dante per sempre! Le esperienze che contano sono spesso quelle che non avremmo mai voluto fare, non quelle che decidiamo noi di fare, ha lasciato scritto il grande Alberto Moravia e, per Dante, quella terribile e traumatica dell’esilio fu l’esperienza che più contò nella sua vita ma di cui egli riuscì a fare e a rendere qualcosa di particolare. Caduto nella trappola della malapolitica, egli fa, innanzitutto, della propria individuale vicenda un fatto universale, cercando, come la famosa mosca di Wittgenstein, di uscire come meglio possibile dalla bottiglia in cui si è andata ad infilare e quella che poteva sembrare una crisi irreversibile dagli esiti più infausti finisce per diventare un’occasione: la più grande occasione della sua vita! Dante sembra aver anticipato, di alcuni secoli, le celebri parole di Albert Einstein sulla crisi: […] La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dalle difficoltà come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. […] Senza crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non ci sono meriti. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi sfuggiamo alle nostre responsabilità e non maturiamo. […]. Ecco: la crisi in cui venne a trovarsi diventò per lui, così geniale, una grande occasione e una grande sfida che lo renderanno ancora più responsabile, lo faranno maturare, crescere fino a diventare un gigante, un gigante capace di fare dell’esilio un punto di forza e un particolare punto di vista, un particolare osservatorio che gli consentirà di analizzare a distanza, in lontananza (e meglio che da vicino) la realtà, il mondo e quello stesso emblematico microcosmo di malvagità che si era rivelata Firenze. Quella di Dante sarà un’analisi lucida e corrosiva della società e della realtà come della vita politica del suo tempo e un’analisi fatta dall’interno e non dall’esterno; fatta da un uomo che era pur sempre parte dell’élite, della classe dirigente e, nel farla, ci mette dentro tutta la sua passione e la sua ideologia che troviamo espressa nelle sue opere maggiori e soprattutto nella Commedia. La presa di coscienza sulla realtà, sulla vita e sul mondo sarà davvero totale, a 360 gradi e la Commedia ne è la più grande testimonianza, drammatica e sublime allo stesso tempo: qui emerge il forte carattere di un uomo e di un poeta e, come dice Eraclito, il carattere dell’uomo è il suo destino; qui appare anche l’uomo che, come dice Friedrich Shelling, è un abisso di passato, un abisso che condiziona da subito il poeta che è in lui già da ragazzino, quando incontra per la prima volta Beatrice, che porterà con lui fino alla fine.
In verità – ripeto – ci troviamo di fronte a un gigante: un gigante della letteratura, da Super-Premio Nobel, che andrebbe dichiarato, una volta per sempre, Patrimonio Universale dell’Umanità. Per gli italiani è certamente Patrimonio Sacro e Inviolabile perché il nostro Poeta-Vate per eccellenza, cantore e interprete del presente e del futuro della nostro paese e, quindi, del suo destino, ha dato all’Italia una duplice identità: un’identità linguistico-culturale, proprio creando una koinè, una lingua comune che parliamo (la più bella!) e una delle letterature più importanti e interessanti del mondo e, allo stesso tempo, un’identità storico-nazionale quando ancora l’Italia come nazione e come Stato non c’era (ci sarà solo più di cinque secoli più tardi). L’Italia e l’idea stessa d’Italia politicamente non c’erano ma c’era e ci sarà nella mente di tanti scrittori e artisti italiani. La repubblica italiana delle lettere c’era, non c’era ancora quella politica. Nella Divina Commedia l’Italia c’è e per questo Dante, insieme a Petrarca (virtù contra a furore prenderà l’arme, e fia el combatter corto; chè l’antico valore nell’italici cor non è ancor morto), a Machiavelli e poi ad Alfieri, Foscolo e Manzoni è stato visto come uno dei Padri del nostro Risorgimento e, diciamolo pure senza téma di esagerare, il primo grande Padre della Patria. E, se riflettiamo bene, anche dell’Europa moderna che, nella sua mente eccelsa, nel suo straordinario intelletto, c’era (e nella Commedia è qua e là citata) e l’avvertiva non solo come una grande entità geografica da tenere unita ma anche come una grande identità culturale dell’Occidente da difendere. Che, insomma, la Divina Commedia sia non soltanto un libro nazionale ma universale e identitario lo testimonia anche un’inchiesta effettuata nel 2007 dalla giornalista di la Repubblica, Simonetta Fiori, presso l’Università “La Sapienza” di Roma appunto sulla centralità del poema sacro nel sistema letterario mondiale e, tra l’altro, l’articolista commentava (14 giugno 2007) che: Sono Dante e Goethe, Shakespeare e Cervantes i quattro autori che abitano stabilmente la coscienza letteraria europea, accompagnati a breve distanza da una costellazione di altri autori – Tolstoj e Flaubert, Joyce e Omero – che godono pur in varia misura dello stesso privilegio. Dante è il timoniere dell’Europa dei colti, di un’Europa in cui la letteratura è fattore d’identità prima ancora dell’economia e della politica. Se, dunque, le cose stanno così, allora non si è sbagliato Giuseppe Antonio Borgese a scrivere, nel lontano 1937, che: L’Italia non fu fatta da re o capitani; essa fu la creatura di un poeta: Dante. […] Non è un’esagerazione dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per Israele… (3-Continua)