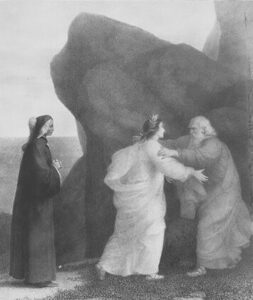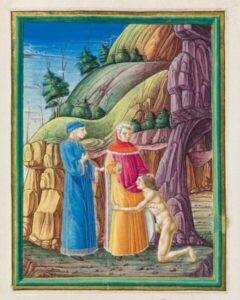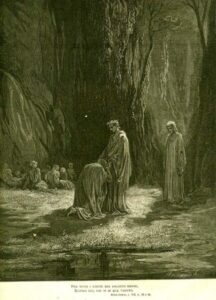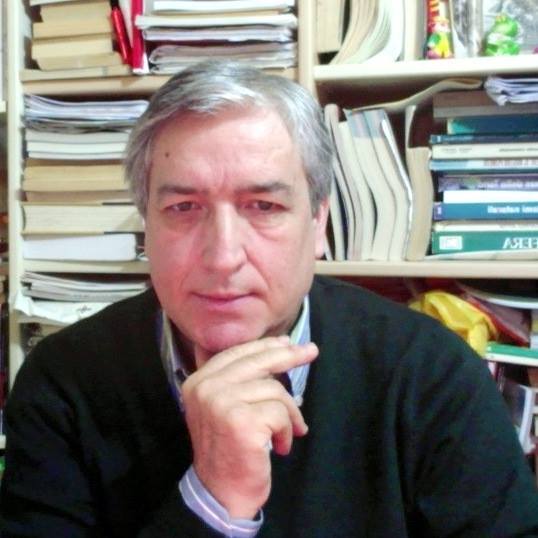
Trebisacce-24/05/2024: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie /Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del sesto canto del Purgatorio di Dante,

Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del sesto canto del Purgatorio di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo nel 2022. Protagonista è Sordello da Goito o, meglio, la grande e celebre invettiva-urlo-denuncia contro la serva Italia di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta . È una delle invettive dantesche più dure e polemiche di tutta la Commedia, tuttora attuale.
Il canto-capitolo VI ovvero il canto di Dante-Sordello-da-Goito e del disperato urlo-j’accuse sulla serva Italia di dolore ostello, nave sanza nocchiero in gran tempesta nonchè sui politicanti che si atteggiano a grandi uomini politici. Antipurgatorio. Secondo balzo. Altri negligenti morti di morte violenta. Si tratta di una nuova schiera di pentiti in extremis, quando la loro fine improvvisa e violenta li ha spinti verso l’Aldilà e si sono affidati alla pietà divina. Incontro con altre anime-cadaveri-eccellenti: Benincasa da Laterina, Guccio dei Tarlati, Federico di Guido Novello dei Conti Guidi, Gano degli Scornigiani, Conte Orso Alberti, Pier della Broccia (o de la Brosse). Virgilio spiega a Dante come le preghiere possano giovare alle anime purganti, espianti. Incontro con il doppio, o alter ego che dir si voglia, di Dante, Sordello da Goito, mantovano come Virgilio. Dopo il fraterno e caloroso abbraccio dei due poeti, Dante coglie l’occasione (proprio grazie ad esso) per interrompere la narrazione e lanciare, con la tecnica narrativa della digressione, la sua appassionata e accorata invettiva-urlo-denuncia contro la degenerata, lacerata e divisa Italia, dove le città si fanno continua guerra civile, fratricida, l’un contro l’altra armata. L’urlo prosegue contro la Chiesa corrotta e politicizzata, contro l’Imperatore, figura assente, che sembra aver dimenticato i suoi doveri verso l’Italia e il mondo; ma c’è anche il preoccupante silenzio di Dio (Dio forse tace perché ha un suo imperscrutabile disegno?) e, alla fine, dulcis in fundo, nella digressione non manca la malata Firenze e la sua emblematica situazione politica, sociale e morale. Insomma, una Firenze e un mondo malati, da catastrofe, senza capo né coda. Il contrappasso è sempre lo stesso. (Tutto si svolge intorno alle ore 3 del pomeriggio del giorno di Pasqua del 10 aprile del 1300).
Il canto-capitolo VI, tra i più belli del romanzo della Commedia, è forse anche quello più politico dell’intera opera, quello in cui la passione e l’impegno politico e civile di Dante appaiono in tutta la loro grandezza e drammaticità del tono e della visione. Si tratta, insomma, di uno di quei canti che, insieme agli altri due sesti canti dell’Inferno (il canto di Ciacco e dei golosi) e del Paradiso (il canto di Giustiniano) costituisce la triade dei cosiddetti canti politici della Commedia. Ebbene, dovremmo finirla una volta per tutte di parlare dei tre sesti canti politici come se la Politica, negli altri canti non ci fosse. E, invece, la Politica è sparsa un po’ ovunque nella Commedia e, insieme all’Etica, è una delle principali protagoniste, che va a coincidere e a confondersi poi, con l’altra protagonista che è la Storia, cioè la vita degli uomini di ieri, di oggi e di domani. Non a caso la Storia c’è sempre nel capolavoro dantesco, anche quella più strettamente contemporanea ricostruita da cronisti come il Villani o il Compagni.
In verità, però, nella Commedia, un po’ tutti i canti-capitoli sono politici, soprattutto quelli dell’Inferno. Diremo di più: tutta la Commedia è politica e la politica, intesa nel senso e nell’accezione più ampia e alta della parola, è presente dappertutto e ovunque. E questo a dimostrazione che la passione civile, politica di Dante fu sempre forte e sempre sentita, anche quando decise di prendere le distanze dai suoi amici e rivali politici. Nel sesto del Purgatorio, Dante lancia una lunga invettiva-urlo che inizia con i celebri versi: Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! Un vero e proprio grido di dolore per la misera condizione in cui è caduta l’Italia, la povera patria, il paese guasto, una volta giardin de lo ‘mperio, e ora, da quando non c’è più l’Impero, divisa e lacerata, serva di tiranni, un vero e proprio casino, luogo di meretricio dove a prevalere sono il disordine, la corruzione e il Male nell’accezione più vasta; e questo non solo in Italia ma nel mondo intero, perché è solo con Cesare che la Terra è meglio governata e più giusta dal punto di vista etico, cioè nella condotta degli uomini. In Italia (ma anche altrove) a prevalere non è l’amore ma l’odio, la violenza, la discordia e la prepotenza: Vieni a veder la gente quanto s’ama!, dice ancora (con amara ironia) rivolgendosi idealmente all’Imperatore Alberto d’Asburgo e, oggi, siamo messi veramente male: Chè le città d’Italia tutte piene son di tiranni, ed un Marcel diventa ogni villan che parteggiando viene: l’Italia è piena di politicanti e avventurieri della politica che non sono altro che piccoli e arroganti tiranni e il primo dei villani, di quelli che vivono nel contado, si presenta sulla scena come oppositore dell’Impero, sentendosi come un novello Caio Claudio Marcello (console fedele a Pompeo, che fu avversario di Giulio Cesare) e, con la loro fazione, il loro partito si adoperano per compiere il Male invece del Bene…
Il canto-capitolo inizia accennando alle altre anime che si affollavano intorno a Dante pregandolo di essere ricordate da lui sulla terra per le preghiere in suffragio che avrebbero potuto giovare per sconti di pena, per un gradito indulto, e prosegue, poi, facendo risaltare la figura del più importante trovatore italiano, Sordello da Goito, la cui solennità e il cui atteggiamento sdegnoso e austero servono a Dante per farne il proprio portavoce e per lanciare il suo veemente, disperato e commovente urlo-j’accuse contro l’Italia, il Papato, l’Imperatore e lo stesso Dio che appare come assente e silente (il silenzio di Dio…) e, infine contro l’amata-odiata Firenze. Insomma, la scena con l’indignato Sordello gli serve per entrare in scena lui, l’autore-demiurgo della Commedia che, fingendo che quella sia una digressione che interrompe il racconto e devia momentaneamente dalla trama narrativa, lancia la sua dura polemica e la sua globale contestazione a 360° (che è anche la più celebre, quella più popolare e quella più citata): contro tutto e tutti, contro il particolare e l’universale, contro il micro e il macro, contro il piccolo e il grande, contro l’umile Italia, paese guasto, dove nulla va bene, contro il mondo senza la guida pacificatrice dell’Imperatore, come contro Dio che sembra aver abbandonato la Terra e l’Universo (sue creature) al proprio destino. Grande e globale contestazione che è poi quella che Dante lancia lungo tutta la Commedia. La Commedia stessa è pensata da lui in questa direzione. E bisogna dire che il mondo terreno, la realtà della vita terrena ritorna sempre nella Commedia, è sempre presente anche quando la materia appare tutta spirituale, teologica e mistica come nel Paradiso.
Ma andiamo a vedere come il canto-capitolo inizia continuando nel racconto delle tante anime che vanno appresso a Dante e gli chiedono quella che noi chiameremmo una raccomandazione: Mi raccomando, visto che tu ritornerai nel mondo dei vivi, cerca per noi chi potrà pregare per le nostre anime, al fine di poter abbreviare il tempo della pena e dell’espiazione. Pertanto, la ripresa della narrazione viene fatta utilizzando la tecnica della similitudine, sempre così calzante e così efficace nel completare e ridefinire il quadro narrativo, rendendo più incisivo il racconto. Questa volta la similitudine è basata sul gioco (molto diffuso ai tempi di Dante) della zara, ovvero dei tre dadi (zara: dall’arabo zahr, quindi al francese hasard e poi all’italiano azzardo: gioco d’azzardo fatto con i dadi che, negli statuti comunali, era vietato): si lanciavano, gettavano tre dadi e si doveva indovinare da subito, in anticipo quali numeri sarebbero usciti, ovvero la loro somma. Per chi perdeva eran dolori, mentre per chi vinceva era la felicità. La sconfitta brucia sempre, si sa, in ogni situazione. Quanto alla folla dei curiosi e degli sfaccendati che stavano lì non solo per divertirsi – una volta terminato il gioco – cercava di seguire il fortunato giocatore per vedere se era così generoso da regalare qualche moneta (si sale sempre, opportunisticamente, sul carro del vincitore…). Ebbene, Dante si sente proprio come il fortunato giocatore che, con la folla di anime che lo segue per raccomandargli di essere ricordata sulla Terra, cerca di allontanarsi come può, quasi di difendersi dal suo assalto, perché non sa più cosa dire e promettere a tutti coloro che gli si rivolgono. Dopo la similitudine, Dante stende anche un elenco di personalità delle classi dirigenti, di uomini appartenenti ai ceti più alti morti di morte violenta.
E dunque: Quando si parte il gioco de la zara, colui che perde si riman dolente, repetendo le volte, e tristo impara; con l’altro se ne va tutta la gente; qual va dinanzi, e qual di dietro il prende, e qual dallato li si reca a mente; el non s’arresta, e questo e quello intende; a cui porge la man, più non fa pressa; e così da la calca si difende. Tal era io in quella turba spessa, volgendo a loro, e qua e là, la faccia, e promettendo mi sciogliea da essa. Quiv’era l’Aretin che da le braccia fiere di Ghin di Tacco ebbe la morte, e l’altro ch’annegò correndo in caccia. Quivi pregava con le mani sporte Federigo Novello, e quel da Pisa che fé parer lo buon Marzucco forte. Vidi conte Orso e l’anima divisa dal corpo suo per astio e per inveggia, com’ e’ dicea, non per colpa commisa; Pier da la Broccia dico; e qui proveggia, mentr’è di qua, la donna di Brabante, sì che però non sia di peggior greggia:
Quando il gioco della zara termina, colui che perde resta dolente (addolorato) e provando a ripetere (con gesto della mano o anche mentalmente le gettate dei dadi, come se dicesse a se stesso: Dov’è che ho sbagliato? La prossima volta non devo più sbagliare!…), e rattristato (rammaricato) cerca di imparare (e far tesoro degli errori commessi, che non deve più ripetere); con il vincitore (invece) se ne va tutta la gente; chi gli va davanti, e chi lo tira, prende di dietro, e chi dal lato (dal fianco) cerca di farsi notare e tenere a mente (si autoraccomanda per il futuro…); egli non si ferma, e ascolta ora questo e poi quell’altro; non si accalca più (si allontana, non insiste) colui al quale ha dato qualcosa, una moneta con la mano, e così si difende (riesce a difendersi) dalla calca (dalla pressione della folla: l’arte di difendersi dalla folla che preme!…). Nella stessa situazione (del giocatore vincente) mi ero trovato io in mezzo a quella folla (schiera) numerosa di anime, e volgendo verso di loro il viso ora di qua e ora di là, promettendo (le preghiere) riuscivo a liberarmi da loro.
Qui c’era l’aretino Benincasa da Laterina che ha trovato la morte (è stato ucciso) dalle braccia crudeli (feroci) di Ghino di Tacco, e Guccio dei Tarlati da Pietramala (ghibellino, annegato in Arno per sfuggire all’inseguimento dei guelfi al seguito della famiglia dei Bostoli di Arezzo o forse perché inseguito in battaglia a Campaldino o nello scontro di Bibbiena), annegato mentre era inseguito (mentre fuggiva).
Fermiamoci un momento. Benincasa da Laterina fu podestà di Bologna nel 1285 e noto e notevole giureconsulto che, come giudice, aveva fatto condannare alla decapitazione il padre e anche uno zio del famigerato brigante, criminale senese Ghino di Tacco, di nobile famiglia di La Fratta, figlio del conte ghibellino Tacco di Ugolino dei Cacciaconti. Ghino (che, per alcuni, era una sorta di Robin Hood e di ladro gentiluomo alla Lupin) signoreggiava nel castello di Radicofani (suo quartier generale) ed era il terrore della Maremma, grande ladro e assassino che, un giorno, per vendicarsi, durante un processo a Roma, entrò in tribunale e uccise e decapitò il Benincasa, senza che nessuno osasse di impedirglielo. In seguito, Ghino sarebbe stato fatto Cavaliere di San Giovanni (oggi Ordine di Malta) e Friere (frate) dell’ospedale di Santo Spirito da Bonifacio VIII, col quale si era riconciliato per via del trattamento da lui riservato all’abate Beltrando di Cluny che aveva rapito: pare che con una certa particolare dieta, gli aveva miracolosamente guarito il mal di stomaco. Fortuna dei criminali!: anche ai nostri tempi il criminale Enrico De Pedis, uno dei capi della famigerata Banda della Magliana, forse per chissà quale servizio reso al Vaticano, risulta essere sepolto all’interno della cripta della basilica di Sant’Apollinara…
Questo grande criminale (al quale il Boccaccio ha dedicato una novella in cui appare brigante buono) ha avuto, in tempi recenti, una certa fortuna: Bettino Craxi, ex leader del Partito Socialista Italiano (PSI) nonché Presidente del Consiglio per molti anni, amava firmarsi con lo pseudonimo di Ghino di Tacco (il giustiziere, quello che fa giustizia dicendo verità scomode…) sul quotidiano ufficiale del suo partito, l’Avanti! Come se fosse un bell’onore utilizzare cotanto nome!… In politica si può anche essere un po’ spregiudicati (Machiavelli docet!), ma firmarsi con il nome di un pregiudicato, di un grande criminale e grande ladro come Ghino di Tacco, ebbene vuol dire proprio che si è toccato il fondo. E, infatti, nell’Italia di fine anni Ottanta e inizio anni Novanta del Novecento il fondo si toccò davvero: la corruzione, la degenerazione, l’illegalità e la criminalità politico-economica delle classi dirigenti, che Dante denuncia per tutta la Commedia, era dilagante e fiumi di miliardi finirono nelle tasche dei partiti al potere e soprattutto in quelle di Craxi e del suo partito, alla faccia del finanziamento pubblico dei partiti… Venne a galla tutto il marcio che c’era nel rapporto tra politica e mondo degli affari, dell’imprenditoria e scoppiò Tangentopoli o Mani Pulite e il processo al Palazzo che Pasolini aveva già chiesto per la corrotta e scandalosa Democrazia Cristiana. Ma il Palazzo, nonostante la travolgente inchiesta milanese di magistrati coraggiosi come Antonio Di Pietro, Pier Camillo Davigo e altri ancora, il Palazzo avrebbe continuato a commettere, con estrema faccia tosta e sicura, tutto sommato, dell’impunità, i suoi bei reati contro la collettività e per il proprio particolare, generando sfiducia e antipolitica nel Paese. La famosa questione morale denunciata da Enrico Berlinguer, capo del Partito Comunista Italiano, prima di morire, resta sempre attuale come tuttora attuale resta la denuncia di Dante. Ma ritorniamo alla rassegna dei personaggi che Dante incontra.
Qui pregava (anche) con le mani protese (verso Dante) in atto di preghiera Federico Novello (figlio di Guido Novello dei conti del Casentino, che aveva avuto come madre una figlia di Federico II; fu ucciso forse nel 1291 dai suoi parenti guelfi), e Gano (o Farinata) degli Scornigiani, che ha fatto apparire virtuoso e forte d’animo (il padre) Marzucco (il quale era un noto e valente uomo politico, poi francescano, che, quando il conte Ugolino della Gherardesca fece uccidere il figlio, non chiese vendetta ma perdonò gli assassini di Gano). Ho visto il conte Orso degli Alberti (assassinato dal cugino Alberto nel 1286) e l’anima separata (divisa) dal suo corpo per astio e per invidia, come egli ha detto, e non per (aver) commesso una colpa; dico (parlo) di Pierre de la Brosse; e Maria di Brabante provveda (ripari) al male commesso finchè è ancora su questo mondo, affinchè non debba far parte di una peggiore schiera (cioè tra i dannati dell’Inferno). (De la Brosse fu un importante chirurgo, che ottenne il favore di Filippo III l’Ardito, re di Francia; fu accusato da Maria di Brabante, seconda moglie di Filippo, di alto tradimento e fu fatto impiccare. In tal modo, la donna si era vendicata dell’accusa a lei rivolta da Pierre secondo il quale aveva fatto uccidere il figliastro Luigi per favorire il proprio figlio Filippo il Bello nella successione al trono).
Dopo questa veloce e triste rassegna, carrellata di morti ammazzati, di delitti e cadaveri eccellenti (da cronaca nera della politica e del Potere) che per Dante erano il segno della profonda crisi morale, della crisi dei valori e degli ideali più nobili e più alti e del prevalere della corruzione e della degenerazione politico-sociale, il pellegrino (che si è finalmente liberato dall’accerchiamento di quelle anime che si raccomandavano a lui per le preghiere), si rivolge a Virgilio chiedendogli di sciogliergli un dilemma, un dubbio proprio sul tema, sulla questione delle preghiere, prendendo come spunto di riflessione un passo dell’Eneide; Virgilio spiega, delucida e, alla fine, dice che, a suo tempo, Beatrice (la Fede, la Teologia) gli avrebbe chiarito meglio i suoi dubbi. Intanto si avvedono che, un po’ distante da loro, se ne sta sola soletta un’anima (è Sordello) che certamente saprà indicare ai due viandanti la via giusta per proseguire nella scalata, nella salita senza sbagliare: Come libero fui da tutte quante quell’ombre che pregar pur ch’altri prieghi, sì che s’avacci lor divenir sante, io cominciai: “El par che tu mi nieghi, o luce mia, espresso in alcun testo che decreto del cielo orazion pieghi; e questa gente prega pur di questo: sarebbe dunque loro speme vana, o non m’è ‘l detto tuo ben manifesto?”.
Ed elli a me: “La mia scrittura è piana; e la speranza di costor non falla, se ben si guarda con la mente sana; ché cima di giudicio non s’avvalla perché foco d’amor compia in un punto ciò che de’ sodisfar chi qui s’astalla; e là dov’io fermai cotesto punto, non s’ammendava, per pregar, difetto, perché ‘l priego da Dio era disgiunto. Veramente a così alto sospetto non ti fermar, se quella nol ti dice che lume fia tra ‘l vero e lo ‘ntelletto. Non so se ‘ntendi: io dico di Beatrice; tu la vedrai di sopra, in su la vetta di questo monte, ridere e felice”.
E io: “Segnore, andiamo a maggior fretta, ché già non m’affatico come dianzi, e vedi omai che ‘l poggio l’ombra getta”.
“Noi anderem con questo giorno innanzi”, rispuose, “quanto più potremo omai; ma ‘l fatto è d’altra forma che non stanzi. Prima che sie là sù, tornar vedrai colui che già si cuopre de la costa, sì che ‘ suoi raggi tu romper non fai. Ma vedi là un’anima che, posta sola soletta, inverso noi riguarda: quella ne ‘nsegnerà la via più tosta”:
Non appena mi sono liberato da tutte quelle anime che pregavano solo affinchè altri (i vivi) pregassero per loro, per (poter) affrettare (accelerare) la loro beatificazione (il loro passaggio allo stato di beatitudine) io ho incominciato (a parlare): Pare che tu, che sei la mia luce (il mio faro, la Ragione che guida e illumina), neghi chiaramente in un passo (dell’Eneide) che una preghiera possa modificare i decreti stabiliti da Dio, e questa gente prega solo per questo: dunque, la loro speranza sarebbe vana, oppure il tuo pensiero non mi è molto chiaro?
Virgilio replica così: La mia scrittura è chiara (quello che scrivo è ben chiaro); e la speranza di costoro non è fallace (non si inganna) se si giudica (se si guarda) con intelletto retto (senza pregiudizi, con la mente libera da pregiudizi); poiché l’altezza del giudizio di Dio non si abbassa (non viene scalfita, non si modifica) per il fatto che l’ardore di carità dei fedeli compie in un istante quanto deve soddisfare (la divina giustizia) chi dimora (chi ha sede) qui nel Purgatorio (insomma: il decreto di Dio vuole la soddisfazione e questa è offerta con la penitenza, con l’espiazione della pena o con la carità e le preghiere di un vivo); e laddove ho sostenuto (affermato) questo argomento (questo concetto) era proprio così perché il difetto di espiazione non poteva essere emendato (corretto) attraverso la preghiera, per il fatto che essa non poteva giungere a Dio in quanto quelli che la dicevano erano pagani e, quindi, privi della Grazia divina. Ma tu, comunque (tuttavia) non fermarti davanti a un dubbio così arduo (profondo; ancora una volta, i limiti della Ragione a spiegare le cose divine), se prima non te lo chiarisce (spiega) colei (Beatrice, la Teologia, la Fede, la Grazia divina, la Rivelazione) che sarà (e farà da) luce (e da tramite) tra il vero (la verità) e la tua mente (il tuo intelletto, appunto, illuminandolo e aprendoti le porte della verità); non so se hai capito; parlo di Beatrice: tu la vedrai ridere felice sulla vetta (cima) di questo monte (del Paradiso Terrestre).
E Dante, sentendo il nome della sua Beatrice (immagine di Dio), si galvanizza, si eccita, si sente di dover accelerare, di proseguire con fretta, vigore ed entusiasmo il cammino: (O mio) signore, procediamo più speditamente (con maggior fretta) perché io non mi sento più stanco come prima, e ormai puoi vedere che il monte proietta la sua ombra (sono le prime ore del pomeriggio).
Virgilio replica così: Noi cammineremo (procederemo, andremo avanti) finchè sarà giorno, quanto più ormai possiamo (quanto più potremo) ma il fatto (le cose) stanno in altro modo da come tu pensi (oppure: le cose stanno in modo diverso da come tu credi che siano: Dante crede che sia possibile arrivare alla sommità del monte in quello stesso giorno). Prima che tu arrivi lassù (sulla cima del monte), vedrai risorgere (più di una volta) il sole, che già si va nascondendo dietro la costa del monte, per cui tu non rompi i suoi raggi proiettando la tua ombra (non fai più ombra come prima). Ma vedi là un’anima che, seduta (tutta) sola (in solitudine: perché è assorta nei suoi profondi pensieri sul destino dell’Italia e del mondo), guarda verso di noi: quella ci insegnerà (indicherà) la via più breve (per salire). (Quel ma vedi là richiama alla mente il vedi là Farinata che s’è dritto…del X canto-capitolo dell’Inferno e anche l’atteggiamento austero e pieno di sdegno di Sordello fa pensare a lui).
A questo punto inizia il colloquio con il grande trovatore Sordello da Goito (Mantova), poeta che scrisse anche poesie di impegno politico e civile, con una vita da romanzo. Nato agli inizi del 1200 da famiglia di piccola nobiltà, era stato alla corte del conte Riccardo di San Bonifacio, signore veronese, che aveva sposato Cunizza, la sorella del crudele tiranno Ezzelino da Romano. Donna di facilissimi costumi (che Dante tuttavia collocherà nel Paradiso perché nell’ultima parte della sua esistenza aveva cambiato totalmente il proprio sistema di vita), Cunizza aveva fatto perdere la testa anche a Sordello che se n’era tanto invaghito da rapirla e da aiutarla a farla fuggire, anche con l’aiuto dei fratelli di lei, Ezzelino e Alberto. Sordello (che pare fosse molto avvenente e tombeur de femmes) si era poi spostato nella Marca Trevigiana, presso varie corti, ma il suo matrimonio segreto con Otta di Strasso lo costrinse ancora alla fuga. Sulla sua vita pendevano oscure minacce di morte. Intanto, era andato presso altre corti in Provenza e poi al servizio di Carlo d’Angiò, il quale gli diede alcuni feudi in Abruzzo, dove morì il 1269 o il 1270. Poeta che scrisse in lingua provenzale (lingua d’oc), secondo la tecnica trobadorica, di lui è ricordato il famoso planh (lamento) Compianto in morte di ser Blacatz (nobile della Provenza onesto e dal grande animo, tanto generoso con i trovatori), in cui attacca e rimprovera severamente, con veemenza, con sferzante tono satirico, prìncipi e sovrani europei accusandoli di inettitudine e viltà e invitandoli a cibarsi del cuore di ser Blacatz, ovvero del coraggio e della virtù di costui per poterne acquistare un po’; inoltre, anche nel poemetto Ensenhamen [insegnamenti, precetti] d’onor aveva rivolto una dura invettiva contro i prìncipi, contro i potenti del suo tempo con pesanti e veementi accuse. Per questo, Dante sceglie Sordello per la scena che gli serve per lanciare la sua più celebre e popolare invettiva di tutta la Commedia. E lo sceglie perché, in verità, si identifica in lui, è come una sua proiezione, un alter ego: costretto di corte in corte, come lui, a cercare e chiedere ospitalità (poeta cortigiano suo malgrado), costretto allo status di fuggitivo in quanto minacciato di morte e come lui poeta, intellettuale engajé, di impegno politico e civile, che se deve sporcarsi le mani e puntare il dito contro l’incapacità e la viltà dei potenti della Terra, delle teste coronate d’Europa lo fa senza alcuna remora e senza alcun timore. Insomma, Sordello è figura esemplare, paradigmatica, simbolica e a Dante interessano queste figure-modello, figure-esempio e le fa spiccare, risaltare per lanciare, qua e là, i suoi alti e universali messaggi. Purtroppo, i modelli, le figure esemplari, quelle che dovrebbero costituire un esempio, appunto, da imitare per ben vivere nella vita civile e sociale, sono ben pochi, una rarità e, infatti, Dante ci fa vedere, con il suo potente realismo, un Sordello in estrema solitudine, una vox clamantis in deserto che se ne sta fiero, altero, sdegnoso, con volto austero, severo, fermo, dignitoso e che incute rispetto e quasi timore, proprio come un leone quando sta riposando. Virgilio gli domanda qual è la via più breve e più agevole per salire il monte ma lui non risponde e, invece, vuole sapere chi sono e da dove vengono e, quando il maestro pronuncia la parola Mantova, ecco che la comune origine, la comune terra dei natali spinge l’appartato Sordello ad uscire dalla sua splendida e pensierosa solitudine e a correre verso Virgilio per abbracciarlo fraternamente, proprio quello che dovrebbero fare tutti gli italiani invece di odiarsi e farsi guerra tra di loro! Ecco, questo è l’esempio che tutti i potenti delle città d’Italia e quelli del mondo intero dovrebbero seguire per vivere con i loro popoli fraternamente e in pace! Ma così non è. E allora non resta che un amarissimo sfogo, un urlo disperato, quasi impotente, da lanciare come un angosciato, durissimo j’accuse che dal particolare (la serva Italia) si estende all’universale (la Chiesa corrotta, politicizzata e scandalosamente poco spirituale, fino all’Imperatore e allo stesso Dio colpevolmente assenti e silenti, colpevoli di aver abbandonato gli uomini e il mondo al proprio infelice destino di vivere senza pace, senza giustizia e con il Male e il Diavolo che la fanno da padroni assoluti).
Insomma, la rassegna dei morti ammazzati, dei cadaveri eccellenti che Dante ci ha fatto conoscere non sono stati elencati tanto per riempire la pagina ma servono al Poeta per polemizzare aspramente con l’Italia divisa e lacerata dei suoi tempi e con il mondo intero che gli appariva sempre più dominato dal Male, dall’assordante silenzio di Dio (che forse premedita qualche bene futuro per l’umanità, a noi ignoto e incomprensibile?…) e dall’assenza, dalla vacanza della figura dell’Imperatore che, secondo Dante, in collaborazione con una Chiesa pura e spirituale, avrebbe potuto far regnare l’ordine, la pace, la giustizia, il bene, l’amore e la felicità dei popoli. E, invece, ci troviamo di fronte a un mondo tutto alla rovescia, da rifare; in Italia (che una volta era alla testa del mondo, con la Roma dei Cesari, e giardino dell’Impero, la più bella tra le nazioni dell’Europa e del mondo) in Italia regna il caos, tra le città-stato e tra i potenti signori e prìncipi, tra i Montecchi e Cappelletti (che sembrano anticipare gli odi tra i Montecchi e i Capuleto di Shakespeare) che le governano prevale l’odio e la volontà di farsi la guerra invece di stare in pace e di vivere in solidarietà, mentre la politica, che una volta era fatta di grandi figure, di grandi personalità ora si è ridotta a politicanti che fanno i tiranni, a gente, a villani che si improvvisano esperti di politica e si atteggiano a grandi uomini senza esserlo…E non parliamo poi di Firenze, ormai sprofondata nel caos, nel disordine, nell’anarchia, nella lacerazione, nella corruzione, nella degenerazione della politica e delle élites che la fanno…Firenze, la grande ammalata, la grande inferma, la grande corrotta che, per risorgere, avrebbe bisogno di una rivoluzione politica e culturale a 360°, come occorrerebbe, del resto, per il mondo intero, per il macrocosmo di cui il microcosmo della città di Dante non è che una proiezione, una metafora dell’universale entropia che domina sulla Terra, sull’aiuola che ci fa tanto feroci (Paradiso, XXII). E se ben riflettiamo, soprattutto negli ultimi vent’anni del XXI secolo, non stiamo vivendo una crisi della politica e di leadership, sia in Italia che in Europa, come lamenta Dante per i suoi tempi? E l’Italia non sembra il più delle volte una nave sanza nocchiere in gran tempesta e un grande e scandaloso bordello politico in cui piccoli, spregiudicati, superbi, arroganti e prepotenti politicanti si atteggiano, si danno le arie di essere chissà quali grandi statisti, quali grandi uomini politici a cui guardare con timore e riverenza? A nostro modo di vedere, esemplari, dei nostri tempi, di tal fatta sono certamente individuabili nei populisti e demagoghi Silvio Berlusconi (Forza Italia), Matteo Salvini (capo della Lega), Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia, partito di provenienza neofascista) e il populista e demagogo a sua insaputa Matteo Renzi (ex Partito Democratico e poi leader del partitino di Italia Viva), il Grande Rottamatore della sinistra italiana, ovvero di quel poco che era rimasta nel nostro paese.
E, dunque, vediamo la breve scena del dialogo tra Virgilio e Sordello (che Dante ha voluto separato dalle altre anime, come in un posto a parte, non precisato, ma distante dai morti ammazzati e dai cadaveri eccellenti, frutto dell’odio e delle divisioni politiche di ceti dirigenti assetati di Potere, di ricchezze, di proprietà, più propense al proprio particulare, al proprio interesse anziché al bene comune), scena alla quale viene fatto seguire l’espediente tecnico della digressione per lanciare l’accorata e violenta invettiva con apostrofe finale riservata a Firenze: Dante dice che la digressione non la riguarda ma, in verità, la sua amata-odiata città è tra i protagonisti principali della digressione, del canto-capitolo insieme a Sordello che è, però, comprimario e anzi fa da spalla, in quanto è utilizzato da Dante proprio come exemplum, come personaggio emblematico che gli può dare lo spunto per lanciare la sua disperata denuncia, il suo drammatico, disperato urlo-j’accuse, che si svilupperà in un monologo interiore, quasi un flusso di coscienza che, irrefrenabile, sgorga dall’alta coscienza etico-politica del Poeta-profeta estremamente preoccupata delle sorti, del destino di Firenze, dell’Italia e del mondo intero: Venimmo a lei: o anima lombarda, come ti stavi altera e disdegnosa e nel mover de li occhi onesta e tarda! Ella non ci dicëa alcuna cosa, ma lasciavane gir, solo guardando a guisa di leon quando si posa. Pur Virgilio si trasse a lei, pregando che ne mostrasse la miglior salita; e quella non rispuose al suo dimando, ma di nostro paese e de la vita ci ‘nchiese; e ‘l dolce duca incominciava “Mantüa…”, e l’ombra, tutta in sé romita, surse ver’ lui del loco ove pria stava, dicendo: “O Mantovano, io son Sordello de la tua terra!”; e l’un l’altro abbracciava.
Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello! Quell’anima gentil fu così presta, sol per lo dolce suon de la sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa; e ora in te non stanno sanza guerra li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode di quei ch’un muro e una fossa serra. Cerca, misera, intorno da le prode le tue marine, e poi ti guarda in seno, s’alcuna parte in te di pace gode. Che val perché ti racconciasse il freno Iustinïano, se la sella è vòta? Sanz’esso fora la vergogna meno. Ahi gente che dovresti esser devota, e lasciar seder Cesare in la sella, se bene intendi ciò che Dio ti nota, guarda come esta fiera è fatta fella per non esser corretta da li sproni, poi che ponesti mano a la predella. O Alberto tedesco ch’abbandoni costei ch’è fatta indomita e selvaggia, e dovresti inforcar li suoi arcioni, giusto giudicio da le stelle caggia sovra ‘l tuo sangue, e sia novo e aperto, tal che ‘l tuo successor temenza n’aggia! Ch’avete tu e ‘l tuo padre sofferto, per cupidigia di costà distretti, che ‘l giardin de lo ‘mperio sia diserto. Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, uom sanza cura: color già tristi, e questi con sospetti! Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura d’i tuoi gentili, e cura lor magagne; e vedrai Santafior com’è oscura! Vieni a veder la tua Roma che piagne vedova e sola, e dì e notte chiama: “Cesare mio, perché non m’accompagne?”. Vieni a veder la gente quanto s’ama! e se nulla di noi pietà ti move, a vergognar ti vien de la tua fama. E se licito m’è, o sommo Giove che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? O è preparazion che ne l’abisso del tuo consiglio fai per alcun bene in tutto de l’accorger nostro scisso? Ché le città d’Italia tutte piene son di tiranni, e un Marcel diventa ogne villan che parteggiando viene.
Fiorenza mia, ben puoi esser contenta di questa digression che non ti tocca, mercé del popol tuo che si argomenta. Molti han giustizia in cuore, e tardi scocca per non venir sanza consiglio a l’arco; ma il popol tuo l’ha in sommo de la bocca. Molti rifiutan lo comune incarco; ma il popol tuo solicito risponde sanza chiamare, e grida: “I’ mi sobbarco!”. Or ti fa lieta, ché tu hai ben onde: tu ricca, tu con pace e tu con senno! S’io dico ‘l ver, l’effetto nol nasconde. Atene e Lacedemona, che fenno l’antiche leggi e furon sì civili, fecero al viver bene un picciol cenno verso di te, che fai tanto sottili provedimenti, ch’a mezzo novembre non giugne quel che tu d’ottobre fili. Quante volte, del tempo che rimembre, legge, moneta, officio e costume hai tu mutato, e rinovate membre! E se ben ti ricordi e vedi lume, vedrai te somigliante a quella inferma che non può trovar posa in su le piume, ma con dar volta suo dolore scherma…
Dunque: Noi siamo andati da lei: o anima lombarda (Dante sa già chi è, di chi si tratta, nonostante faccia spesso finta di non riconoscere i suoi interlocutori), come te ne stavi altera e con sdegno (nella tua solitudine) e onesta, dignitosa e lenta nel muovere lo sguardo (gli occhi; un atteggiamento davvero regale, da uomo di altri tempi, sembrerebbe dire Dante, che vede gli uomini privi di veri valori e inseguire quelli falsi e bugiardi). Essa non diceva nulla (stava in silenzio, non parlava) ma ci lasciava passare (camminare) soltanto guardando come fa un leone quando si riposa (sta fermo; sguardo fiero e degno di rispetto). Solo (pur) Virgilio (oppure, meglio: tuttavia, nonostante tutto, cioè nonostante quell’atteggiamento così “scostante”) si è recato da lei (si è avvicinato a lei) pregandola di indicarci la strada migliore (più agevole per salire sul monte); e quella non ha risposto alla sua domanda, ma ha chiesto del nostro paese e della nostra vita (cioè da dove venivamo e sulla nostra storia, condizione civile), e il dolce Virgilio ha incominciato: Mantova…, e quell’anima (quell’ombra) che (fino a poco prima) se n’era stata tutta raccolta in se stessa (nella sua orgogliosa solitudine), è balzata (come in un improvviso scatto, all’impiedi, si è drizzata) ed è corsa verso di lui dal luogo dove stava prima, dicendo: O mantovano, io sono Sordello, della tua stessa terra!, e si sono abbracciati l’un l’altro.
(Un lungo affettuoso, commovente ed emblematico abbraccio che, per Dante, dovrebbe essere un sincero embrassons-nous universale, l’abbraccio collettivo degli uomini e dei popoli per il bene dell’umanità e per creare finalmente un mondo fondato sull’amore, la pace e la giustizia. E, così, da questa apparentemente semplice scena di un caloroso abbraccio tra due poeti conterranei, Dante trova lo spunto, il pretesto, l’occasione per lanciare il suo biblico urlo di uomo che parla nel deserto, sperando che qualcuno lo ascolti. Irrompe qui – scrive con acutezza Anna Maria Chiavacci Leonardi, nel suo commento edito da Mondadori nel 1994 – la grande passione che tenne l’animo di Dante per tutta la vita, passione morale e politica insieme, di fronte all’ingiustizia del vivere civile, e al rovinare delle istituzioni in cui egli credeva. Il suo solenne e profetico ammonimento ai potenti della terra – che qui risuona in modo eminente – è una delle prime ragioni per le quali è nato il poema. Non a caso, gli uomini e gli scrittori del nostro Risorgimento hanno visto nel grido di Dante, nel suo lamento, nel suo compianto per l’Italia e il suo destino, il simbolo dell’amor patrio e Dante stesso il primo grande Padre della Patria, il profeta del nostro Risorgimento).
Dunque: Ahi (povera patria!…) Italia (ridotta a) serva (serva e corrotta perché priva della guida dell’Imperatore e preda di tiranni e degli appetiti delle potenze straniere), luogo (sede) di dolore (di sofferenza) nave senza guida (timoniere, pilota) in una grande tempesta (di passioni, cupidigia e odi sfrenati e feroci, suggerisce opportunamente il Sapegno), non più signora delle nazioni (dei popoli, come ai tempi di Roma; domina provinciarum la definiva il Corpus Iuris di Giustiniano), ma un postribolo (un luogo di corruzione, di meretricio; un grande casino, direbbe, forse, il Poeta, con il linguaggio dei nostri giorni).
Quella nobile anima (di Sordello) è stata così rapida (pronta, svelta) a far festa al suo concittadino, qui (proprio nel Purgatorio, dove pure la sola patria è quella celeste e dove ciò che lega alla terra dovrebbe essere superato, o molto attenuato) al solo sentire il dolce nome della sua terra; e, invece, sulla terra (in Italia) i tuoi abitanti non riescono a stare (a vivere) senza farsi guerra, e l’un l’altro, i cittadini di una stessa città, chiusa nello stesso recinto di mura o di fossato (tipici della città medievale) si dilaniano (perché si odiano). Guarda (scruta) o misera (Italia), i tuoi mari lungo i lidi (o: le rive dei tuoi mari, cioè le tue regioni costiere) e poi guarda (scruta) nel tuo stesso seno (nei tuoi territori interni) se riesci a trovare una sola parte di te (di terra o di mare) che vive in pace (c’è odio e guerra dappertutto…). A cosa è servito che Giustiniano (ti accomodasse, riaggiustasse la briglia) ti rimettesse in ordine con le sue leggi (ovvero): a cosa serve il Codice giustinianeo, se non c’è chi lo applica, chi lo faccia applicare (per reggere in maniera salda ed efficace lo Stato)? (La metafora dello Stato come cavallo e di chi lo guida come cavaliere, cioè colui che sta in sella, si trova già nel Convivio. La sella vuota è metafora della vacanza imperiale, dell’assenza di un imperatore che guidi il mondo intero, assenza che si è sentita forte a partire dalla morte di Federico II di Svevia). Senza quel freno (cioè il freno delle leggi raccolte da Giustiniano), la vergogna sarebbe minore (come dire: non ci sono le leggi e, dunque, è normale che ci sia tutto questo caos, questo disordine, questa deriva di odi, violenze, guerre, ecc. ma, essendoci, è ancora peggio…). Ahi gente (uomini) di Chiesa che dovreste essere devoti solo a Dio (alle cose dello spirito invece di pensare alle cose terrene), e lasciar sedere Cesare sulla sella (cioè affidare il potere temporale, politico all’Imperatore e lasciarlo governare) se ben si comprende l’insegnamento (il dettato) della Sacra Scrittura (date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio), guardate come questa bestia (cavallo selvaggio, indomito che è oggi l’Italia) è diventata riottosa (ribelle) per non essere più guidata dagli sproni (dell’Imperatore) da quando tu (Chiesa) hai preteso di tenere in mano le redini (cioè di sostituirti alla guida, di guidarla senza esserne capace, in quanto non sai imporre la pace e la giustizia, anzi, sei una delle cause principali della corruzione, della degenerazione, della violenza e delle guerre in Italia e nel mondo). Oh Alberto tedesco (d’Asburgo) che abbandoni costei (l’Italia, occupandoti soltanto della Germania) che è diventata (cavallo) indocile (ribelle all’Imperatore), mentre invece dovresti inforcare i suoi arcioni e domarla (guidarla, ebbene) cada (pure) dal cielo una giusta (ed esemplare) punizione (l’apostrofe dantesca si fa anatema) sulla tua stirpe (colpevole dell’abbandono dell’Italia al suo destino di disordine e di violenza), e (tale punizione, poi avvenuta già con Dante vivo) sia insolita (inedita) tremenda e ben chiara (evidente) tanto che il tuo successore (che sarà Arrigo VII di Lussemburgo) ne abbia timore (terrore). Poiché tu e tuo padre avete tollerato (permesso) in nome della cupidigia (degli interessi e del potere) nei domini (nelle terre) tedesche (della vostra Germania), che il giardino dell’Impero (cioè l’Italia, la regione più bella di tutto l’Impero) fosse stata abbandonata (e lasciata al suo destino: l’Italia come paese guasto e terra desolata…). Vieni (scendi in Italia e vieni…) a vedere come le potenti famiglie (delle città d’Italia, divise in fazioni) si fanno guerra: i Montecchi (di Verona, del partito filoimperiale) e i Cappelletti (o Capuleti, di Cremona, antimperiali), i Monaldi (ghibellini e, quindi, filoimperiali) e i Filippeschi (di parte guelfa, entrambi di Orvieto, nell’Italia centrale), (o Alberto I d’asburgo) uomo incurante dei propri doveri: i primi già battuti (sconfitti) e i secondi col presentimento di esserlo! Vieni, o uomo crudele, vieni e guarda la condizione dolorosa di umiliazione in cui si trovano i signori ghibellini (i filoimperiali, cioè conti, marchesi e altri che erano feudatari) e cerca di rimediare ai guasti e danni da loro commessi; e potrai vedere (vedrai, se scendi in Italia) com’è (tristemente) decaduta la contea di Santafiora (feudo degli Aldobrandeschi, nella regione del Monte Amiata)! Vieni a vedere la tua Roma (perché è lei la sede dell’Impero) che, nella solitudine (ormai sola perché priva di te) piange, e giorno e notte ti chiama (ti invoca come gridando disperatamente): Cesare mio, perché non stai con me (perché non mi fai compagnia, a me che sono tua sposa, perché non mi guidi)? Vieni a vedere come le genti (le popolazioni d’Italia) si amano! (Qui c’è amara ironia: vieni a vedere come si odiano e sono lacerati e divisi in fazioni che si fanno guerra!…) e se nessuna pietà (compassione) di noi ti muove (ti scuote, allora) vieni a vergognarti della tua fama (vieni a vedere quanto è grande il tuo discredito e provane vergogna). E se mi è lecito (permesso di chiederti), o Gesù Cristo (sommo Giove, così nel Medioevo si scriveva per dire Cristo) che sei stato crocifisso per noi sulla Terra (che ti sei immolato per salvare gli uomini) la tua giustizia (gli occhi tuoi giusti, che si sono allontanati da noi,) sono rivolti altrove? Oppure (tutto quello che ora accade) è forse preparazione che tu fai nell’abisso imperscrutabile (insondabile) della tua sapienza (della mente divina), di qualche bene futuro, che è così lontano dalla nostra capacità (possibilità) di comprendere? (Se Dio è Bene e non può se non volere il Bene, allora dev’essere così). Perché le città d’Italia son tutte piene di tiranni (i signori che giungevano al Potere senza vantare alcun titolo legittimo), e ogni villano (i parvenus provenienti dal contado) che sa destreggiarsi nelle fazioni (nei partiti) diventa un Marcello (si atteggia a novello Marcello, cioè a politicante arrogante, a tirannello, a superbo e arrogante uomo di potere, avversario dell’Imperatore. Gaio Claudio Marcello, console nel 50 a. C., fu pompeiano e fiero avversario di Cesare; qui diventa simbolo degli avversari dell’Imperatore, ma con valenza evidentemente negativa e di disprezzo).
(L’ultima apostrofe della grande e lunga invettiva-urlo-j’accuse di Dante è riservata al microcosmo fiorentino, alla corrotta, degenerata e violenta Firenze, in piena crisi politica e morale, ormai senza più alti valori e ideali e, pertanto, simbolo e, praticamente, allegoria del caos, del disordine, dell’entropia che regnano sovrani nel mondo intero, che Dante vede andare fatalmente in rovina e destinato alla catastrofe): Firenze mia, puoi ben essere soddisfatta (contenta; c’è forte ironia fino al sarcasmo) di questa digressione che non ti tocca (non ti riguarda affatto, e invece come le tocca!…), grazie al tuo popolo che si ingegna (si adopera) tanto (nel ben operare, e che, quindi, fa di tutto per evitare gli strali, le stoccate di questa digressione: ma tutta la frase è ironica e anzi sarcastica). Molti uomini (non a Firenze!…) nutrono nel cuore (nell’animo) il senso della giustizia, ma esso si manifesta con prudenza attraverso le parole, per evitare di emettere (dare) giudizi senza ponderazione (hanno timore di sbagliare); i tuoi cittadini, invece, hanno sempre la giustizia sulla bocca (sulle labbra). Molti uomini (non a Firenze!…) rifiutano il peso delle cariche pubbliche; non così (però) i fiorentini che, subito pronti, rispondono (all’appello…) senza neppure esser stati chiamati: Io sono pronto a sobbarcarmi questo peso! (Sono pronto ad assumermi l’onere, sono pronto a rimboccarmi le maniche!: l’ironia, anzi il sarcasmo è davvero pesante!…). Ora puoi essere lieta (rallegrati) perché hai ben di che rallegrarti (ne hai molti motivi): tu sei ricca (ma di quelle ricchezze, di quel denaro che è fonte di corruzione, degenerazioni, divisioni e violenze), vivi nella pace (cioè nella guerra e nelle lacerazioni politiche) e vivi (ti conduci) con tanto senno, tanta saggezza (con la saggezza di chi è sempre in guerra civile, fratricida per il potere politico e il proprio particulare). Se io dico la verità (il vero, la realtà) lo mostrano i fatti (i fatti parlano chiaro!…). Atena e Sparta (Lacedomone), che hanno fatto le antiche leggi (Solone e Licurgo) e sono state così civili (così ben governate) hanno fornito appena un accenno (un saggio del buon governo e) del buon vivere civile se confrontato a te, tu che emani (produci) tante sottili leggi (deliberazioni, provvedimenti) che a metà novembre non arriva quello che hai deciso (deliberato) ad ottobre (tanto il filo tessuto è sottile e fragile…). Quante volte, del tempo che puoi ricordare (in questi ultimi tempi) hai mutato (cambiato) leggi, moneta, cariche pubbliche e costumi, e rinnovato i tuoi cittadini (nel governo della città, in quanto i Bianchi cacciavano i Neri e viceversa). E se ben ricordi e hai ancora capacità di discernere, potrai vedere te stessa (potrai paragonarti, calzante similitudine!…) a quella inferma che non riesce a trovare riposo (pace) nel suo letto, e cerca di rimediare e trovare un po’ di sollievo per il suo dolore (per le sue sofferenze) rigirandosi nel letto (cambiando posizione, girandosi un po’ di qua e un po’ di là; insomma, è una città-malata irrequieta, incostante, che cambia posizione politica ogniqualvolta e non sa decidersi per una scelta chiara e definitivamente giusta per il bene comune che, per Dante, è accettare la guida dell’Imperatore, delle forze imperiali e non della corrotta e avara Chiesa)…
L’amarissima invettiva, con apostrofe finale riservata alla sua emblematica Firenze, finisce, dunque, per essere metafora, anzi allegoria generale per dire che in quella situazione versano tutta l’Italia e il mondo intero e, in tutto questo, Dio sembra così assente e silente. L’Italia è un paese malato, un paese guasto e il mondo è anch’esso così. La salvezza potrebbe venire soltanto da un mondo governato, guidato da un organismo universale, sovranazionale, cioè l’Impero, il solo capace di imporre la Pace e la Giustizia. E Dante, ancora una volta, con una potente e indimenticabile invettiva da Inferno, si conferma poeta del mondo terreno, con un occhio che guarda verso l’alto, verso il cielo e un altro che guarda verso il basso, verso la Terra, che è così bella ma resa un inferno dagli uomini che la abitano più propensi al Male che al Bene. Ieri come oggi, no? Insomma, come si è già rilevato e sottolineato, tutta la Commedia è una gigantesca e continua contestazione della realtà, dello status quo, dello stato di cose presente, direbbe Marx, che Dante vorrebbe superare opponendogli il suo capolavoro con tutti gli alti messaggi che contiene per l’umanità per l’oggi e per il domani. Pertanto, ci appare calzante e in sintonia con il nostro pensiero, quello che ha scritto Pietro Cataldi (Dante e la nascita dell’allegoria. Il canto I dell’”Inferno” e le nuove strategie del significato, Palumbo, Palermo 2008): […] Se è lecito – e forse doveroso – chiederci perché Dante abbia scritto il poema, non meno lecito – e non meno doveroso – sarà chiederci se noi si sia oggi ancora interessati a quelle ragioni, e nella condizione di condividerle, almeno in parte. Ora, l’idea di salvarsi da una condizione catastrofica inventando nuove forme di ricostruzione del senso appare particolarmente attuale […].
La Commedia è stata composta anche contro qualcosa; anzi, si ha spesso l’impressione che gli obiettivi polemici siano nel poema ancor più nettamente definiti che non le finalità positive. Dante si scaglia contro religiosi e politici corrotti, contro valori sociali che hanno pervertito ogni possibile buona convivenza umana, contro abitudini degli individui che li distolgono dalla salvezza per asservirli ai disvalori collettivi e alla corruzione pubblica; ma fissa anche l’origine comune di tutta questa rovina in un’entità di alto valore simbolico, che anima il male nelle sue varie forme: il denaro, l’oro, la ricchezza. D’altra parte la civiltà del guadagno fondava proprio in quei decenni una possibilità di relazione fra cose e significati che ne ridislocava fatalmente il valore: acquistando un prezzo, e sempre più coincidendo nella communis opinio con un prezzo, le cose vedevano attenuarsi il proprio significato trascendente. La secolarizzazione del mondo procedeva quale secolarizzazione dei valori del mondo; secolarizzandosi, il valore delle cose rivelava un fondamento esclusivamente convenzionale, cioè nessun fondamento. […] Dante, appartenendo per formazione a una società ancora non pregiudicata dai nuovi valori borghesi, e avendo anzi istintivamente rafforzato i propri legami culturali con una fase perfino precedente dello sviluppo storico, idealizzandone i valori, era nella specialissima condizione di vedere i lineamenti albali di un mondo colonizzato dalla logica del guadagno senza averne ancora interiorizzato i valori e la inevitabilità. Dante riesce dunque a vedere tragicamente, per così dire nella sua interezza, l’orrore; quell’orrore del quale è parte non secondaria la facoltà di assuefare e omologare. Dante vede infine un mondo già simile per molti aspetti al nostro, e dal quale comunque il nostro sarebbe derivato, con gli occhi di una diversa e contraria epoca storica. Ne deriva, come sappiamo, che la Commedia è forse l’opera più duramente distruttiva della letteratura occidentale: l’intera società contemporanea del poeta è rifiutata e scagliata dentro la nera voragine dell’Inferno.
Contro la secolarizzazione del mondo, Francesco d’Assisi è promosso, nell’XI del Paradiso, al titolo di “sole” (v. 50)e anche in altro modo paragonato a Cristo (v. 72) […]. L’“ignota ricchezza” (Par., XI, v. 82) esaltata nella povertà costituisce un consapevole rovesciamento del comune sentire. […]
Fra gli innumerevoli luoghi del poema nei quali Dante avrà modo di riprendere la critica […] alla civiltà del guadagno, uno ha un rilievo particolare rispetto all’assetto complessivo del canto proemiale: “La tua città, che di colui è pianta / che pria volse le spalle al suo fattore / e di cui è la ’nvidia tanto pianta, / produce e spande il maladetto fiore / c’ha disviate le pecore e li agni / però che fatto ha lupo del pastore” (Par., IX, 127-132). Il maledetto fiorino era, nel mercato internazionale dei cambi, la principale valuta di riferimento (come oggi il dollaro o l’euro), anche in forza della scelta di coniarlo in oro zecchino; e la fortuna economica e mercantile di firenze dipendeva anche dalla centralità della sua moneta. Tanto più forte risulta dunque l’invettiva dantesca, intenzionata a cogliere, come dietro la povertà francescana un’autentica ricchezza, la rovina disposta dal successo apparente della ricchezza. Fra denaro e Lucifero non c’è differenza: la città seminata da Satana è la stessa che trionfa nei mercati con la sua moneta d’oro; anzi da quel trionfo deriva che la città sia figlia di Lucifero…
Intanto, nel canto-capitolo successivo la polemica e la contestazione di Dante contro i Potenti della Terra, sulle loro pecche, sui loro limiti, sulla loro inettitudine a ben guidare i popoli, ecc. prosegue, anche se con tono pacato e meno duro. Con le sole armi della parola poetica, letteraria.